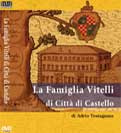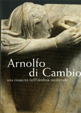| |
Scrive Angiola Romanini: "Alla base dell'arte arnolfiana sta una “figura” in cui è compenetrata in sintesi tutta la realtà. E in questa sintesi sta la ragione per cui egli appartiene di diritto alla civiltà gotica europea”. Molte sono - a tutt'oggi - le incertezze intorno alla figura e all'opera di Arnolfo. Documentato dal 1265 come discepolo di Nicola Pisano, identificato tradizionalmente come figlio del leggendario Lapo, architetto tedesco d'origine, Arnolfo acquista definitivamente un'ascendenza (figlio di Cambio) e una patria (Colle Val d'Elsa) solo nel secolo scorso.
Nonostante la costante attenzione della critica e gli studi a lui dedicati, l'artista rimane tuttora difficilmente inquadrabile e l'ambito della sua attività rimane di dubbia definizione. Arnolfo è indubbiamente architetto: come tale firma il ciborio di San Paolo Fuori le Mura, a Roma, nel 1285; è ingegnere (come dimostra la sua attività giovanile per Carlo d'Angiò), urbanista, scultore e conoscitore dell'antico e forse - stando alle appassionate ipotesi della Romanini - pittore, qualora lo si voglia identificare con il Maestro di Isacco, autore delle celebri scene nella Basilica Superiore di Assisi.
E' Giorgio Vasari a costruire, nelle "Vite", una prima "fortuna" per Arnolfo, delineando per lui un personaggio poliedrico, capace di restituire dignità all'architettura dopo i presunti "secoli bui", svolgendo - tra l'altro - un ruolo fondamentale nel rinnovamento urbanistico e architettonico di Firenze e nella nascita delle "terre nuove": San Giovanni Valdarno, Castelfranco e Terranuova.
|
|